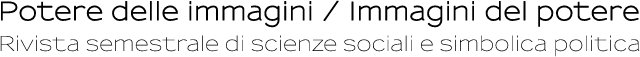
n. 4 / gennaio 2014
Serial power. La politica impolitica delle serie tv
n.3 / luglio 2013
Annisettanta
n. 2 / gennaio 2013
Il viaggio e l'immagine dell'Altro
n. 1 / luglio 2012
Le speranze deluse del POST
n. 0 / gennaio 2012
Che cos’è l’iconocrazia
n. 4 / gennaio 2014
Viaggio nel penitenziario femminile di Orange is the new black
Elisa Fiorucci
Università per Stranieri, Perugia
La prigione: “una caserma un po’ stretta, una scuola senza indulgenza, una fabbrica buia, ma, al limite, niente di qualitativamente differente”. In questo modo definiva la prigione Michel Foucault, che nella sua genealogia del potere disciplinare la presentava come elemento essenziale della panoplia punitiva, adagiato su un doppio fondamento: giuridico-economico – in quanto essa monetizza le pene e stabilisce equivalenze quantitative delitti-durata – e tecnico-disciplinare – grazie alla sua riproduzione accentuata dei meccanismi di disciplinamento del corpo sociale, non troppo diversa da scuole, caserme, fabbriche. Fondata sulla forma semplice della privazione della libertà, oggi la prigione - e il regime carcerario per estensione - non rappresenta più soltanto la legalizzazione del potere disciplinare ma diviene un dispositivo fondamentale di produzione sociale del neoliberalismo ed il nucleo della transizione contemporanea dallo Stato sociale allo Stato penale.
Benché marginalizzato dal dibattito pubblico degli ultimi trent’anni, se non per sparuti richiami e mobilitazioni intorno al tema del sovraffollamento e dell’amnistia, il dispositivo carcerario è la punta visibile di un filo che lega indissolubilmente la politica istituzionale all’economia e alla gestione della criminalità. Il cinema l’ha sempre saputo, la televisione lo sta riscoprendo, grazie al solco tracciato prima da Prisoner e poi da OZ(1) - e recentemente ripreso da Orange is the new Black, prodotto a marchio Netflix in cui l’ingresso in un carcere femminile nello stato pilota del movimento di “law and order”(2) , spalanca dinnanzi allo spettatore le dinamiche di fondo del regime carcerario e le sue innervazioni biopolitiche sui corpi razzializzati e marginalizzati delle donne in esso rinchiuse. Un’operazione che deve essere approfonditamente analizzata alla luce dei fenomeni congiunti di iperincarcerazione e metamorfosi del potere disciplinare in Occidente, cercando di tenersi a debita distanza dal chiacchiericcio informe del gossip mainstream a cui bastano due scene di amore lesbico per etichettare un discorso più complesso che affronta le dinamiche della produzione di soggettività (anche, ma non solo, lesbiche) entro i confini carcerari. Questo perché Orange is the new black non è il prodotto spettacolarizzato di un’industria affamata di clichés e di soldi, ma la trasposizione sicuramente romanzata della storia autobiografica di Piper Kerman, WASP di 34 anni, detenuta per un crimine commesso dieci anni prima, come corriere della droga nel traffico di stupefacenti gestito dalla sua ex compagna.(3) Sebbene alleggerito da momenti di intelligente ironia (tanto da poter parlare di dramedy, mix fra dramma e commedia) nonché da intrecci amorosi che lambiscono la soap opera, Orange is the new black entra nei dettagli dell’istituzione carceraria e delle sue regole, come anche delle dinamiche relazionali che interessano le detenute, restituendoci per immagini alcuni elementi costitutivi della gestione neoliberale della criminalità/marginalità; elementi che tenterò di sviluppare attraverso cinque movimenti influenzati principalmente dalle posizioni teoriche e dagli studi di Loic Waquant, Nils Christie, Lucia Re.
ll primo movimento che lo spettatore non può far a meno di notare, accompagnato dagli occhi della protagonista che sperimenta su di sé le aporie del regime carcerario varcandone la soglia, è l’etnicizzazione della popolazione detenuta. Sopravvivere in carcere equivale a ribadire la propria appartenenza etnica. Il quadro stabile di posizioni e status criminale, condotta e aspettative, è stato sostituito da uno scenario caotico in cui la divisione razziale prevale su ogni identità particolare e influenza tutti gli aspetti dell’esistenza dentro il carcere: le compagnie e le protezioni, l’accesso al vitto, al telefono, alle visite, la possibilità di avere una branda decente su cui dormire, la sezione a cui si è assegnati.(4) La fedeltà alla comunità etnica di provenienza, che viene ritrovata nella prigione, è definita in termini rigidi, senza alcuna chance di mantenere una posizione intermedia o neutrale, pena la marginalizzazione estrema o, peggio ancora, il divenire bersaglio di violenze ed altri soprusi. La divisione orizzontale fra prigionieri appartenenti ad etnie diverse accompagna, pertanto, la tradizionale divisione orizzontale fra prigionieri e secondini.
La protagonista sperimenta immediatamente quelle regole non scritte, sottili, complesse, rigide, che dividono la popolazione carceraria in gruppi ben definiti, la lealtà ai quali è condizione necessaria per la delineazione della propria identità entro il gruppo di riferimento. Tentando ingenuamente di utilizzare la sua fresca ironia per fare amicizia, ma commettendo l’errore grave di criticare il cibo di Red, che ha impiegato anni a costruire la sua autorità come capocuoca, Piper (o meglio Chapman, dato che vige la legge per cui è il cognome ad identificare i soggetti) viene letteralmente emarginata dai momenti di socialità e lasciata senza cibo, motivo per cui dovrà iniziarsi alle rigide dinamiche carcerarie, facendo sua la logica del clan e dell’individualismo for own safeness (vedi episodio 1”I wasn’t ready”). Poiché l’organizzazione sociale carceraria, piuttosto che una reazione alla deprivazione imposta dal carcere, sembra qualcosa che si importa dalla strada, l’affiliazione etnico-razziale è lo status dominante che governa le relazioni e gli spazi. Il codice carcerario tradizionale – incentrato sulla solidarietà fra i prigionieri in opposizione alle guardie - è sovrastato dal codice della strada che ha come imperativo assoluto il rispetto individuale e l’esibizione della forza e dell’autonomia del singolo, sia entro la comunità etnica di riferimento che di fronte alle altre. Come osservato da Johnson, tali dinamiche determinano il passaggio da una Big House repressiva ma sicura ad una giungla instabile e violenta, in cui le relazioni sono affette da fattori di disgregazione, aggressività, imprevedibilità(5). Piper sarà realisticamente costretta a valutare attentamente ogni sua mossa, ogni parola così come ogni silenzio, per fare proprio un codice che non conosce e per evitare reazioni che le si potrebbero ritorcere contro amaramente.
Va peraltro sottolineato il particolare punto di vista proposto sull’universo carcerario, perno centrale di tutta la costruzione seriale. Come rilevato da più parti, la stragrande maggioranza della popolazione carceraria statunitense è oggi composta dai membri di una underclass che popola quelle “no-goes areas” sacralmente separate dalla downtown (spazio ricreativo e di consumo destinata alla classe medio alta e ai turisti): neri e latinos, a cui si aggiungono tossicodipendenti (per lo più appartenenti alle due etnie) e altre marginalità socio-economiche. La figura della donna bianca borghese occidentale, oltre ad essere numericamente minoritaria, rappresenta anche il bersaglio comune delle soggettività escluse dal benessere, che sperimentano sulla propria pelle il grado differenziato di tutela delle minoranze rispetto ai bianchi e la stratificazione delle traiettorie individuali entro il carcere secondo fattori sociali (identità etnica e nazionale, genere, classe) e giuridici (accesso alle risorse legali e ad avvocati esterni, natura dell’infrazione e lunghezza della pena etc) La protagonista diventa, pertanto, il fulcro d’attenzione – per lo più in senso negativo - non solo da parte delle altre detenute, meno fortunate di lei, ma anche delle guardie carcerarie e del personale tutto, che le riserva un trattamento in bilico fra l’empatia e la cattiveria gratuita.
Il secondo movimento che emerge fra le maglie del racconto televisivo è l’esplicitazione, tramite episodi significativi in tal senso ( principalmente gli episodi 5“The Chickening” ,7 “Blood Donut” e 10 “Bora Bora Bora”) della reale funzione del carcere. Sappiamo già, sulla scorta del pensiero di Foucault, che le carceri non sono destinate a reprimere le infrazioni, quanto piuttosto a distinguerle, a distribuirle, ad utilizzarle, ad organizzare la trasgressione delle leggi in una tattica generale di assoggettamento e di produzione della delinquenza.(6) Ma il regime carcerario sviluppatosi dalla metà degli anni ’70 negli Stati Uniti, se da un lato si presenta ancora come principiale dispositivo di gestione della devianza (in cui rientrano una serie di pratiche che vanno dal disciplinamento all’incapacitazione) determina altresì il passaggio dalla retorica della riabilitazione – perno ideologico della penalità moderna - alle reale neutralizzazione dei condannati, sia materialmente (dislocandoli in un’enclave) che simbolicamente (separando nettamente i criminali dai cittadini osservanti la legge). In linea con una missione del tutto identica a quella del ghetto, luogo idoneo a tenere la parte “infetta” della popolazione in quarantena; in una simbiosi mortale fra questo e la prigione, funzionale alla reclusione di una popolazione stigmatizzata per la sua origine etnica e giudicata superflua sul piano economico e politico.(7)
Come ogni carcere americano, anche quello fittizio di Orange is the new black è realisticamente abitato da una maggioranza di donne appartenenti al sottoproletariato urbano e di nere e latino-americane. Un’umanità di scarto, il fallimento della gestione della quale ha determinato il ricorso alla sua temporanea invisibilizzazione e ad una triplice esclusione: dal capitale culturale, dalla redistribuzione sociale e dalla partecipazione politica. Tale esclusione determina a sua volta un continuum fra prigione e ghetto di soggetti provenienti da quest’ultimo e che ne fanno ritorno per poi essere nuovamente arrestati in un crescendo di marginalità socioeconomica e incapacitazione legale. Fenomeno ben evidenziato nell’episodio 12 “Fool me once”, in cui, tra le altre cose, Jefferson detta Taystee, ormai impossibilitata ad avere una vita fuori a causa dell’estrema difficoltà a trovare un lavoro e all’indebolimento dei legami affettivi, commette un reato per tornare in carcere, dove può contare su misere quanto essenziali sicurezze: una branda, delle amiche, un lavoro in biblioteca.
Un terzo movimento mi sembra possa rintracciarsi nell’esplicitazione, attraverso l’intreccio fra la varie soggettività, il loro vissuto, il loro “futuribile”, dello stretto legame tra politiche penali e politiche sociali, legame che spiega il fenomeno di iperinflazione carceraria attraverso la convergenza di fenomeni diversi e intrecciati quali l'indebolimento dei sistemi di welfare, la privatizzazione onnivora e le retoriche securitarie. La crescita ipertrofica dell’istituzione penale e il c.d. “boom penitenziario” fanno infatti parte, come argomenta Waquant, di una ristrutturazione più ampia dello stato americano per andare incontro alle esigenze del neoliberalismo.(8) Determinate politiche penali – come quella della guerra alla droga lanciata da Reagan e continuata dai suoi successori e il passaggio dal sistema dell’ “indeterminate sentencing” a quello di “truth in sentencing” fino ai più recenti provvedimenti di estrema severità ispirati allo slogan “three strikes and you’re out” – hanno prodotto, dal 1973 ad oggi, una crescita generalizzata e senza precedenti in una società democratica del numero dei detenuti, senza un parallelo aumento del tasso di criminalità.(9) L’inasprimento delle pene è ricaduto, come previsto, sulle fasce più basse del sottoproletariato urbano, producendo concretamente la delinquenza - tipo specifico di illegalismo, politicamente ed economicamente meno pericoloso, concentrato, controllato e disarmato e, proprio per questo, direttamente utile.(10) I detenuti sono, per la maggior parte, piccoli delinquenti disorganizzati che non commettono quasi mai crimini gravi ma illegalità di lieve-media entità, entro una strategia di sussistenza mediocre e parassitaria. La vita di Miller fuori dal carcere, rievocata nell’episodio 10 “Bora bora bora”, mostra un’esistenza precaria qualunque nelle strade di New York City, fatta di piccoli furti per mangiare e di una precoce addizione al crack, la “droga dei poveri”.
La prigione rappresenta, dunque, l’emblema dell’avvenuto passaggio dallo stato sociale allo stato penale: la miseria del primo, unita alla diminuzione del suo peso pubblico in campo economico e alla sua subordinazione alle esigenze dell’economia globale, si compensa con l’aumento di potere nel campo del mantenimento dell’ordine pubblico e morale. L’atrofia dello stato sociale (culminata negli Stati Uniti con il Personal Responsibility and work opportunity Act del 1996 che ha rimpiazzato il diritto al welfare con l’obbligo al workfare) e l’ipertrofia subita dallo stato penale sono due sviluppi concomitanti e complementari, che non possono essere analizzati in modo disgiunto e che trovano nel regime carcerario la naturale implicazione della criminalizzazione della povertà.(11) La povertà viene, invero, stigmatizzata come colpa individuale e percepita come virus da debellare per riaffermare il primato ideologico dell’individualismo meritocratico e mettere a tacere i rischi derivanti dall’insicurezza sociale. Sulle detenute di Danbury pesa la colpa di un’incapacità individuale a uscire dal contesto sociale in cui sono risucchiate e che le determina come persone delinquenti, in linea con la figura del “mauvais pauvre” che cela la congiunzione fra politiche sociali e penali, la quale mostrerebbe invece come “la lotta contro la delinquenza di strada fa ormai da pendant e da schermo alla nuova questione sociale”.(12)
Corollario di tale trasformazione – e quarto movimento di questa breve trattazione - è il ricorso alla privatizzazione del settore carcerario e conseguente quotazione in borsa di società che si occupano della gestione delle carceri.(13) Per Christie le caratteristiche essenziali della modernità nel campo del controllo del crimine sono proprio la privatizzazione e la reinvenzione della prigione privata che collocano l’industria di riferimento in una posizione privilegiata rispetto agli altri comparti economici essendo il crimine una risorsa naturale illimitata e non venendo mai a mancare né le richieste di servizio né il capitale per quella che viene considerata sicurezza. “Prigione vuol dire denaro. Tanto denaro. Per gli edifici, per le forniture di materiali e per la gestione.”(14) E dove circola troppo denaro arriva la corruzione, i traffici illeciti, le connivenze istituzionali, in un rimpallo fra pubblico e privato finalizzato al mantenimento degli interessi di entrambi (per il primo il contenimento degli illegalismi e il mantenimento del potere penale, per il secondo gli alti profitti e la presenza di domanda), il tutto a discapito dei soggetti detenuti, delle condizioni e dei servizi a loro destinati. Benché solo sfiorato, tale tema è presente nell’episodio 11“Tall man with feelings”, mentre la natura privata dell’istituzione carceraria con la sua filosofia “aziendale” pervade l’intera serie, negli scambi fra amministratori, guardie ed esponenti politici.
La legittimazione delle sopracitate politiche penali è avvenuta grazie ad un’operazione di divisione netta fra le circostanze sociali e l’atto del delinquere. Il quinto ed ultimo movimento riguarda, appunto la separazione del punto di vista sociologico, esplicativo, da quello del diritto, che regola e sanziona sulla base della responsabilità personale, e la conseguente legittimazione della retorica secondo cui non è la società ad essere responsabile del crimine ma i singoli criminali.(15) La decisione politica di non prendere in considerazione il retroterra socio-culturale dell’imputato per la commisurazione della pena, oltre ad essere foriera di ingiustizie, finisce per escludere l’imputato come persona, producendolo come delinquente. È in quest’ultimo movimento che si situa, a mio parere, l’elemento di maggiore interesse della serie. Nei continui flashbacks di cui si nutre la sceneggiatura, lo spettatore riesce a recepire un’immagine complessa delle protagoniste, legando ciascuna di esse al contesto sociale in cui erano e sono immerse. Attraverso tale operazione – peraltro visivamente azzeccata e nel complesso vincente grazie a movimenti spaziali e temporali che conferiscono un certo ritmo ad ogni puntata – l’invisibilizzazione forzata dei corpi eccedenti che riempiono il carcere femminile viene neutralizzata dalla loro capacità di acquisire una nuova visibilità, che da conto del retroterra sociale delle detenute insieme a tutte quelle piccole cose che sono essenziali alla percezione dell’altro come essere umano completo.(16) Anziché scomparire dietro ai punti di una biografia criminale, le detenute del correctional facility di Danbury riprendono vita attraverso un moto di avvicinamento dello spettatore ad esse, che spezza la frontiera simbolica fra noi e loro. Esibendo, se non la dimensione tragica, quella punitiva del potere.
Movimento conclusivo. Quello di Kenji Kohan è uno sguardo sufficientemente cinico ma anche fortemente analitico, nutrito di un’ossessione per i dettagli e di misurate rivelazioni sul mondo carcerario che fanno della serie una quasi docufiction realizzata “da dentro”. Attraverso l’esibizione del funzionamento di un carcere qualsiasi nello stato di New York, ci avvicina alle modalità dell’esercizio contemporaneo di uno degli aspetti più rilevanti del biopotere in Occidente, un potere che sublima la prigione come dispositivo fondamentale di stratificazione sociale e produzione simbolica. Se in questo racconto non compaiono gli alti salotti del potere istituzionale è innanzitutto perché una volta ceduta la sovranità ad organismi sovranazionali e alle lobbies, agli stati nazionali non rimane che il potere punitivo per il quale non ammettono intromissioni; in secondo luogo perché il focus si mantiene fisso sui corpi e sulla dimensione personale della vita delle detenute, attento ad evitare sensazionalismi di natura intimista ma ricordando, anche allo spettatore, che il personale è politico e che le politiche neoliberali ricadono, prima di tutto, sui corpi, soprattutto su quelli, sacrificali, di una categoria che rappresenta l’antitesi vivente del sogno americano, la cui marginalizzazione e neutralizzazione funziona come una sorta di esorcismo collettivo.
1) OZ è una serie statunitense trasmessa dalla HBO fra il 1997 e il 2003 ed interamente chiusa entro le mura dell’Oswald State Penitentiary. Prisoner è una serie drammatica australiana piuttosto lunga (692 episodi) andata in onda sotto il nome di Prisoner: Cell Block H negli Stati Uniti e in Inghilterra, come Caged Women in Canada fra il 1979 e il 1986 e ambientata nell’immaginario carcere femminile del Wentworth Detention Center.
2) Il movimento Law and Order nasce a New York sotto l’amministrazione di Rudolph Giuliani che ha fatto del principio di “tolleranza zero” l’elemento centrale del suo più ampio programma di governo. Indirizzata nei confronti di una vasta gamma di atteggiamenti considerati contrari all’ordine pubblico, la tolleranza zero è basata sulla convinzione che vi sia continuità fra gli atti di inciviltà ed i reati veri e propri. La riduzione del tasso di omicidi registrato a NY negli anni ’90 ha accreditato l’efficacia di tali politiche repressive. Si veda L. Re, Carcere e globalizzazione: il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa, Editori Laterza, Roma-Bari 2006, pp. 30-34.
3) Kerman, P. (2012), Orange is the new black: My year in a women’s prison, Spiegel & Grau.
4) Cfr.Waquant, L. (2002) Simbiosi mortale: Neoliberalismo e politica penale, Verona, Ombre corte, Irwin, J. (1990), The Felon, Berkeley, University of California Press; Carroll, L. (1982), “Race, Etehnicity and the Social Order of the Prison” in Johnson, R e. Toch, H (eds), The Pains of Imprisonment, Beverly Hills, Sage; Hassine, V. (1999), Life without Parole: Living in Prison Today, Boston, Roxbury Publications.
5) Johnson, Op. cit., pp. 56-77.
6) Foucault, M (1976), Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi, pp. 300-307.
7) Per approfondimenti sul concetto di simbiosi mortale si veda Waquant, Simbiosi mortale cit, con particolare riferimento al capitolo 2 “Simbiosi mortale. Quando ghetto e prigione si incontrano e si intrecciano”, pp 47-107. Lo stesso tema viene ripreso in Waquant, (2004), Punir les pauvres. Le nouveau governement de l’insécurité sociale, Marseille, Agone, pp. 225-236.
8) È questa una riflessione che permea la maggior parte dei lavori del sociologo francese.
9) La mancanza di rapporto fra livello di incarcerazione e tasso di criminalità è stato ampiamente dimostrato dai criminologi più autorevoli, fra cui lo stesso Nils Christie (1996), Il business penitenziario. La via occidentale al gulag, Milano, Elèhthera.
10) “Non è ai margini e per effetto di successivi esili che nasce la criminalità, ma grazie ad inserzioni sempre più strette, sotto sorveglianze sempre più insistenti, attraverso un cumulo di coercizioni disciplinari” scriveva Foucault per spiegare come il “delinquente” fosse un prodotto dell’istituzione carceraria, operazione che porta ad annullare tutte le retoriche essenzialiste su un supposto carattere delinquente irriducibile e sull’origine della delinquenza ai margini della società e della legge. Si veda Foucault, Op cit., p. 333.
11) Il Personal Responsibility and work opportunity Act ha rappresentato un punto di svolta nelle politiche assistenziali americane, grazie alla drastica compressione dei sussidi riservati ai membri più vulnerabili della società (..) e all’imposizione dell’obbligo per quest’ultimi di entrare forzatamente in un mercato del lavoro caratterizzato da salari bassissimi, causando prevedibilmente una maggiore impoverimento delle classi subalterne, finanche la loro totale indigenza. L’istaurazione di un dispositivo sociale così regressivo trova la sua ratio nella finalità ultima di eradicare non tanto la povertà quanto la dipendenza dai programmi sociali, in perfetta sintonia col programma di smantellamento del welfare state sotto i regimi neoliberali, e la sua conferma nelle affermazioni di Bill Clinton, firmatario dell’atto, di aver così mantenuto la promessa fatta agli elettori: "to end welfare as we have come to know it".
12) Waquant, Punir les pauvres cit p. 37 (traduzione mia)
13) Va peraltro ricordato che la privatizzazione non è un fatto nuovo per gli USA dove i primi procedimenti giudiziari erano privati, così come le polizie e le prigioni, gestite dai proprietari di taverne. Persino il modello tradizionale di prigione è stato ideato con la precisa intenzione di trarne profitto: Il panopticon benthamiano , la massima sorveglianza al minimo costo. I primi appaltatori carcerari svilupparono, quindi, soluzioni innovative, poi modificate o assorbite dallo stato. Vedi Christie, Op cit. p. 117.
14) Ivi, p. 96.
15) Tali retoriche sono state propagate soprattutto dai governi Reagan e Bush I. Ricordo, a tal proposito, un frammento del discorso di quest’ultimo: “Dobbiamo alzare la voce e correggere una tendenza insidiosa, la tendenza che consiste nel mettere il crimine sul conto della società piuttosto che su quello dell’individuo […] Per quanto mi riguarda, come la maggior parte degli americani credo, dovremmo iniziare ad edificare una società più sicura mettendoci subito d’accordo sul fatto che non è la società ad essere responsabile del crimine: sono i criminale ad essere responsabili del crimine”, George Bush, “Address to the Students about the War on Drugs”, citato in Green, P e Rutherford, A. (dir) (2001), Criminal Policy in Transition, Dartmoth, Hart Publishing, p. 145 (traduzione mia)
16) “La distanza può essere creata fisicamente da un fucile a lunga gittata, socialmente dalla classe, professionalmente da una studiata incapacità di vedere la persona come se fosse un vicino, un amico o un amante. In una struttura autoritaria una distanza ulteriore si crea agendo secondo gli ordini ricevuti. La tabella delle condanne è simile ad un ordine dall’alto. Il giudice può essere una persona clemente. Può essere sensibile a una vita di miserie. Ma c’è la tabella. Mi dispiace, ma il tuo livello di reato è 38, Ivi, p. 138.
Errori di Casting
di Sabino Di Chio
Saggi
Dalla visione alla vista.
Elementi e pratiche del potere in "House of cards"
di Tito Vagni
"Black Mirror" o della biopolitica postdemocratica
di Salvatore Cingari
L’indispensabile ipocrisia di "The Newsroom"
di Sabino Di Chio
House and Politics
di Giuseppe Cascione
Dans l’œil du "Dr House"
di Hélène Houdayer
Viaggio nel penitenziario femminile di “Orange is the new black”
di Elisa Fiorucci
L'imprinting del reale.
Cronaca e politica nella recente serialità americana
di Antonio Fabbri



